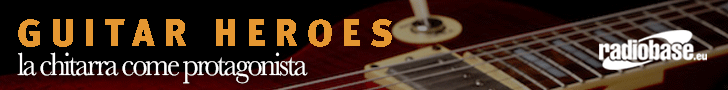In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15
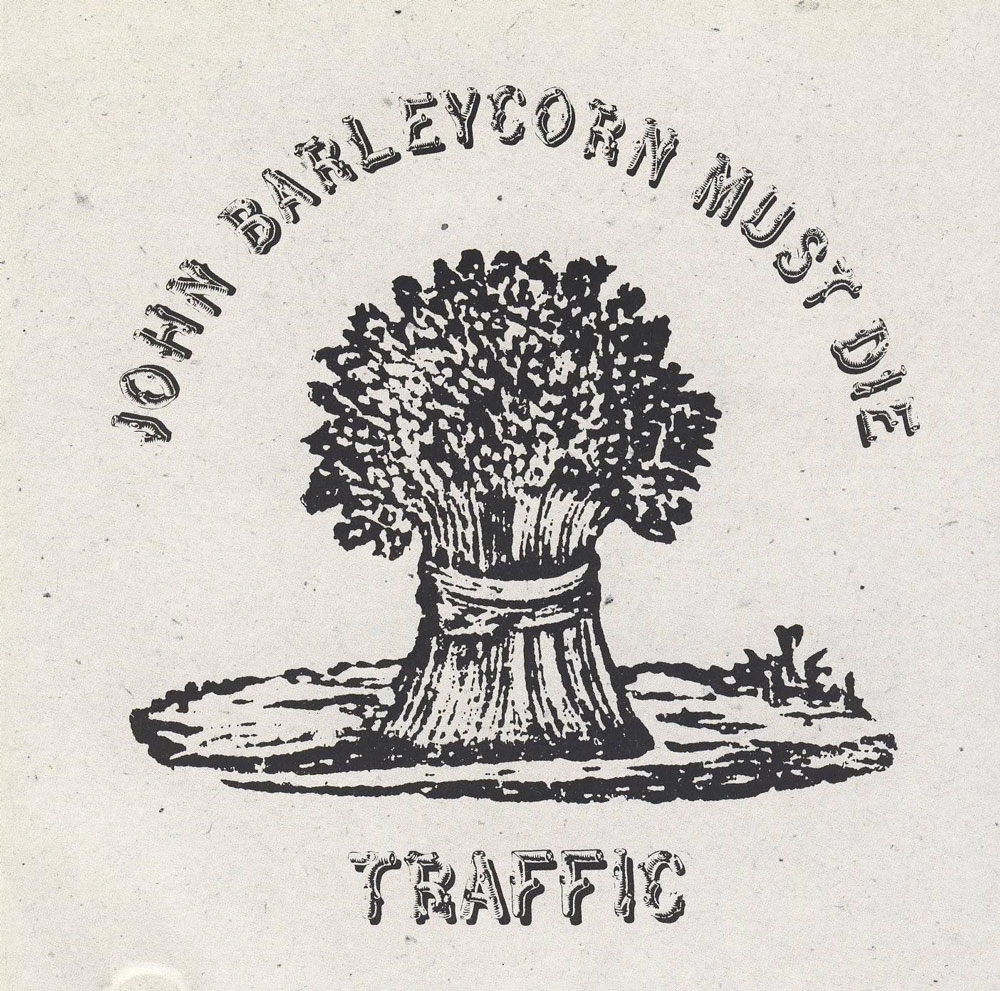
Ascolta il Disco Base della settimana
1. TRAFFIC "Glad"
2. TRAFFIC "Freedom Rider"
3. TRAFFIC "Empty Pages"
4. TRAFFIC "Johnny Barleycorn"
5. TRAFFIC "Stranger To Himself"
I Traffic sono un atipico gruppo britannico, capitanato dal polistrumentismo e dalla sovrannaturale voce di Steve Winwood e dall’elegante percussionismo di Jim Capaldi. Comprimari a questi due leader indiscussi della band sono Dave Mason alla chitarra e Chris Wood al sax elettrico e flauto; a turno e a sprazzi hanno fatto la loro comparsa anche Ric Grech al basso e Jim Gordon in qualità di secondo batterista.
Steve Winwood all’epoca, e ancor prima dell’era Traffic, aveva rivestito un importante ruolo attraverso i suoi trascorsi nello Spencer Davis Group e più precisamente in quella composizione di gusto e ritmica travolgente che è “Gimme Some Lovin'”. Attraverso i Traffic, non ancora ventenne, Winwood completò il suo personale progetto. Jim Capaldi era il socio della ditta, più anziano, ma altamente carismatico, anche se meno scavezzacollo del giovane Winwood, era la mente riflessiva dotata di un ottima vena compositiva e creativa; di solito il batterista è l’essenza “meno” musicale del gruppo, Capaldi invece ne era la tipica eccezione.
I Traffic nel corso della loro carriera hanno toccato varie correnti musicali, si sono avvicinati all’allora nascente rock progressivo, hanno iniettato nel loro background sfumature jazz, in altri casi sonorità soul; il r&b e’ quasi sempre stato presente, e non hanno mai perso di vista la matrice con la quale tutti i componenti del gruppo si erano formati musicalmente: il beat. La loro atipicità risiede nel fatto, che proprio per questo loro variegato modo di intendere e fare musica, difficilmente si sono racchiusi in un genere predefinito, hanno toccato molteplici porti senza mai salpare presso porto alcuno; si sono sempre limitati a intaccare appena la corteccia superficiale di un genere senza mai scendere in profondità, e forse in questo risiede la loro grandezza. Se fossero nati oggi, nel nuovo millennio, forse la loro sarebbe stata etichettata come “musica globale” (tanto per usare una terminologia che fa tendenza) o, meglio ancora, World music.
L’esordio, con “Mr. Fantasy”, è un trionfo di psichedelia, dalla copertina ai suoni, ma è tra anni dopo, con “John Barleycorn” che la band di Winwood perviene al suo capolavoro. Si comincia con “Glad”, pezzo strumentale di quasi sette minuti che per tutta la sua durata non ha mai un attimo di cedimento: una linea melodica pianistica suggerisce un refrain in apertura, e su quel motivo, via via, si arrampicano tutti gli altri strumenti, che a turno e in felice connubio, traggono forza e ispirazione proprio da quell’incastro di suoni diversi prodotti da un basso che pompa note senza un attimo di tregua, da un furbo pianoforte che qua e là appare e scompare, e da un assolo di sax psichedelico nella parte centrale del brano crea un atmosfera da jam session in studio. Jazz, funky, psichedelia, r&b sono la linfa vitale di questo classico, e del suono Traffic, e rintocchi di campane nella parte finale doneranno al tutto una spruzzatina leggera e azzeccata di rumorismo avanguardistico. La successiva “Freedom Rider” si apre con un inquietante piano e un nostalgico sax a introdurre la splendida voce “black” di Winwood, che fin da subito si esercita in vocalizzi che solcano i cieli e rasentano la terra attraverso tonalità multiformi. È una canzone attraversata da una continua vena drammatica, a volte pure insopportabile per il suo crescendo di disperata sofferenza. La ritmica, fra uno stacco e l’altro, crea i presupposti per un ottimo solo di flauto, regalando una sfaccettatura in più ai già tanti umori della canzone: è quel tocco di barocchismo classico di cui, di tanto in tanto, i Traffic hanno fatto uso. Conclusione in pieno trip adrenalinico, con gli strumenti che esplodono in perfetta armonia, creando un muro sonoro granitico, al fine di rendere la canzone stessa totalmente irriconoscibile dalle basi di partenza.
In rapida successione, arriva il terzo classico del disco: “Empty Pages”, con un inizio enfatico subito spezzato da aromi soul, in cui Winwood dimostra fin da subito di sapersi muovere con maestria, tanto alla voce quanto alle tastiere. La parte ritmica è morbida e fluida e allo stesso tempo dura e grintosa negli stacchi, il pianoforte disegna una trama solistica colma di feeling blues nella parte centrale, e l’organo in sottofondo crea una ragnatela molto efficace nel tenere compatto il suono d’insieme. Non ultima per importanza è l’interpretazione vocale di Winwood, senza mai un momento di cedimento nelle note acute e in quelle cantate in falsetto, ma capace anche di suonare dolentemente straziante nelle tonalità più basse.
Si prosegue con “I Just Want You To Know”, strana canzone che altro non è che un ritornello intonato ritmicamente dall’inizio alla fine su cui poggia la melodia; impreziosisce il tutto uno straziante solo di chitarra elettrica in piena distorsione.
I Traffic ci trasportano nel continente Americano grazie a “Stranger To Himself”, con quell’arpeggio puramente “southern” di partenza; l’atmosfera viene pervasa da forti tinte jazz. Ma è solo un momento: si cambia subito scenario, infatti, con un solo dissonante di Mason che riporta in territori tipicamente rock/blues di stampo britannico. I sei minuti e mezzo di “John Barleycorn” segnano un altro dei vertici del disco: non fosse per la voce di Winwood, questa canzone potrebbe benissimo appartenere al catalogo dei Jethro Tull prima maniera. È una folk song scintillante, in cui riecheggiano antiche tradizioni contadine britanniche, sulle note di un romantico barocchismo che si stringe attorno a un delizioso e acustico arpeggio di chitarra e a un flauto in lontananza, che tratteggia ombre fiabesche. Su tutti, domina Winwood, con la sua cantilena dimessa e dal sapore antico, che racconta di vecchie storie in un’atmosfera fiabesca ed emozionante. Folclore sfavillante e ai massimi livelli.
Altra perla del disco è “Every Mother’s Son”, un blues sofferto in cui Winwood tocca corde emotive così in profondità da sembrare quasi crudele. Un organo in sottofondo langue in perfetta simbiosi con una chitarra elettrica sofferta e gemente, che accompagna mano nella mano Winwood alla voce per buona parte della canzone, e che sembra quasi duellare con questa, specie nei frangenti in cui la canzone sale di qualche ottava. Subito dopo un tale sforzo emotivo, l’atmosfera si fa più rilassata: intrecci di organi mescolano sonorità diverse, mentre la sezione ritmica, e soprattutto la batteria, è il motore che alza e abbassa con perfetta scelta di tempi i livelli emozionali della canzone. È una maratona r&b sofferta, da cui tutta la band esce in splendido stato di grazia.
A distendere gli animi, arriva la tenera ballata di “Sittin’ Here Thinkin’ Of My Love”, con un Winwood primattore assoluto sia nella parte vocale, sia in quella strumentale, in cui un accompagnamento pianistico produce un morbido tappeto sonoro per il cantato. Si chiude con “Backstage & Introduction”: soltanto rumori di sottofondo di porte che si aprono e si chiudono, e un un dialogo anonimo, con battiti di mani che si fanno sempre più vicini, e una ovazione che accompagna la presentazione di questo grande gruppo in uno dei suoi molteplici concerti.