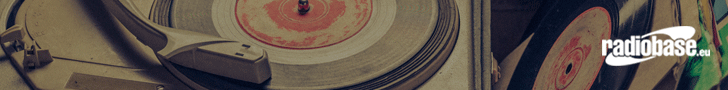Album scelto e commentato da Federica Nota, laureata in comunicazione e media
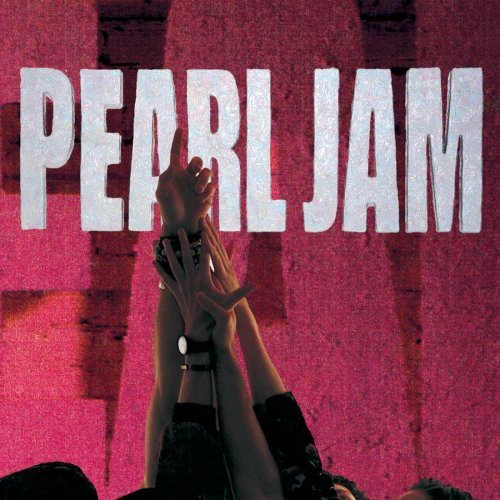
In onda tutte le sere alle 20e15 - 22e15 - 00e15
1. PEARL JAM "Once"
2. PEARL JAM "Even Flow"
3. PEARL JAM "Black"
4. PEARL JAM "Oceans"
5. PEARL JAM "Release"
 Tra il ’91 e il ’92 non si fa altro che parlare di Seattle e del grunge. Ed è nel calderone del grunge che vanno a finire pure i Pearl Jam, assieme ad altri storici nomi come Nirvana, Alice In Chains, Soundgarden, Mudhoney, Screaming Trees e pure Smashing Pumpkins.
Tra il ’91 e il ’92 non si fa altro che parlare di Seattle e del grunge. Ed è nel calderone del grunge che vanno a finire pure i Pearl Jam, assieme ad altri storici nomi come Nirvana, Alice In Chains, Soundgarden, Mudhoney, Screaming Trees e pure Smashing Pumpkins.
Che cos’hanno in comune questi gruppi? Ben poco, a conti fatti. Grunge vuol dire tutto e niente. Il grunge è una tendenza, un atteggiamento, un movimento culturale, più che musicale, che prende piede a Seattle appunto, all’inizio dei 90.
I Pearl Jam sorgono dalle ceneri dei Green River e dei Mother Love Bone: in entrambi i gruppi militavano il chitarrista Stone Gossard e il bassista Jeff Ament.
Fondamentale è l’incontro nel ’90 con Eddie Vedder, surfista californiano, che diventerà il carismatico vocalist della band (che nel frattempo conta tra i propri membri anche un altro chitarrista, Mike McReady; alla batteria, invece, si daranno il cambio diversi talenti, anche se durante le registrazioni di “Ten” sarà Dave Krusen a sedersi ai tamburi).
L’arrivo dei Pearl Jam sulla scena musicale è salutato dagli amanti del rock come l’avvento del messia. Commercialmente parlando, “Ten” è un successo clamoroso, che nel giro di due anni arriverà a vendere oltre dodici milioni di copie solo negli States, superando addirittura “Nevermind” dei Nirvana.
Ma che cos’ha di così speciale il gruppo di Gossard e Ament? Perché “Ten” è considerato una pietra miliare nella storia del rock?
La forza dell’album è il suo essere (ancora oggi) così incredibilmente anacronistico. Niente contaminazioni tra punk e hard-rock come la band di Kurt Cobain. Nessuna incursione nel metal come gli Alice In Chains.
I Pearl Jam riportano in vita, anche nel modo di atteggiarsi sul palco, l’hard-rock degli anni 70. Ascoltando i loro pezzi tornano in mente gli Who (non a caso Pete Townshend è l’idolo di Vedder), i Led Zeppelin, gli Aerosmith, Neil Young, i Lynyrd Skynyrd. Nessuna sperimentazione: le canzoni di “Ten” sono perfette nella loro semplicità. Molto spesso costruite attorno a un unico riff di chitarra, estremamente melodiche e mainstream, sembrano fatte apposta per riempire le arene, rimpiazzando (o muovendosi accanto) gli U2 nel cuore del pubblico mondiale.
I Pearl Jam sono la tanto attesa risposta alle preghiere di milioni di rocker, che in tutto il mondo si lamentavano di gruppi tutto glamour e niente sostanza à-la Bon Jovi.
Con il grunge, il pubblico riscopre la necessità e il piacere di identificarsi con i propri idoli. I Pearl Jam se ne fregano del proprio look, si interessano dei loro fan, regalano sempre show passionali ed energici, per anni combatteranno (anche se alla fine saranno sconfitti) contro la Ticketmaster per abbassare il prezzo dei biglietti per i loro concerti, non vorranno più (o quasi) rilasciare videoclip promozionali da “Ten” in poi.
I Pearl Jam paiono uscire da un’altra epoca, ed è questo ad affascinare fan e critica. La loro indiscussa moralità e tenacia gli fa guadagnare il rispetto anche da chi inizialmente criticava la loro musica.
Il sound di “Ten” è granitico e lontano mille miglia da ogni moda: col tempo la band maturerà, cambierà coraggiosamente strada (non vendendo più milioni di copie), ma non raggiungerà più le vette di passionalità e potenza dell’esordio.
A colpire le giovani generazioni è la sincerità dell’opera, che pesca a piene mani nel passato dei membri della band, ma soprattutto in quello del cantante Eddie Vedder, principale autore dei testi.
“Alive”, forse il brano più famoso dell’Lp, è una lunga ed epica cavalcata rock, che ruota attorno a un immortale giro di chitarra per poi lanciarsi nel finale in una jam che pare non finire mai, comandata da un bellissimo assolo di Mike McReady, che riporta alla mente “Free Bird” dei Lynyrd Skynyrd.
Il testo riguarda il passato di Eddie Vedder, e la traumatica scoperta della morte del padre naturale: per anni la madre del cantante gli aveva tenuta nascosta la vera identità del padre.
Ogni traccia dell’album è lo spaccato, spesso tragico e amaro, delle vite di diversi personaggi. Lo spleen di Vedder, il suo cantato doloroso, la sua voce cavernosa e potente, a metà via tra Jim Morrison e Rod Stewart, si fa eco del disagio di una moltitudine di giovani che si rispecchiano nei personaggi descritti in “Ten”, decretandone da subito il successo.
“Why Go”, graffiante blues, tra le cose migliori del gruppo, racconta di una ragazza rinchiusa in una clinica dai genitori perché scoperta mentre fumava uno spinello. “Once”, feroce incipit dell’album, è il flusso di coscienza di un serial killer; “Even Flow” è un trascinante rock, che si concede una parentesi psichedelica nella parte centrale, dove Vedder si fa cantore delle dure condizioni di vita di un senzatetto.
“Jeremy”, l’altro singolo che ha dato fama internazionale al gruppo, grazie anche al bel videoclip di Mark Pellington, è una ballata dolente ispirata a un vero fatto di cronaca: un adolescente americano che, armato di pistola, aveva fatto strage dei suoi compagni di classe, per poi togliersi la vita.
“Porch” e “Deep” (su una ragazza che ha subito violenza sessuale) sono i brani che si staccano più dal tipico suono del gruppo: se la prima si avvicina al punk, anche se poi nel ritornello torna a essere melodica ed epica in stile Pearl Jam, la seconda invece tenta un’incursione nel territorio metal, più consono, forse, agli Alice In Chains.
Non mancano, infine, momenti più intimisti. “Black” è una splendida ballata, la storia di un amore finito, “sfumato in nero”, che si lascia andare a un lungo, psichedelico finale, in cui emerge anche un pianoforte. “Oceans”, contraddistinta da fragorose chitarre acustiche e da un ritmo animalesco, ricorda molto gli Zeppelin del terzo album, anche se nella parte finale Vedder si concede un falsetto nello stile di Bono.
Molto psichedelica anche “Garden”, ricca di riferimenti religiosi, ma comunque distante dalle vette del disco (e c’è da dire che, in definitiva, tutta la seconda parte di “Ten” non è ai livelli delle prime sei, straordinarie, canzoni), mentre “Release”, un lento brano d’atmosfera, quasi mistico, che si trasforma poi in un’epica cavalcata alla U2, conclude alla grande il disco, con una struggente preghiera di Vedder al padre scomparso.
Durante le sessions di “Ten” sono registrati anche altri brani, tutti ugualmente interessanti, ma non inclusi nell’album. “Yellow Ledbetter”, dal testo enigmatico in cui ricorrono immagini di guerra (nel ’91 siamo in piena guerra del Golfo), è tra le prove più emozionanti del gruppo, così come “Footsteps”, solo chitarra e armonica, in cui il vocalist della band si mette di nuovo a nudo.
“State Of Love And Trust”, forse il pezzo più tirato e divertente della band, e “Breathe” entreranno invece a far parte della colonna Sonora del film “Singles” di Cameron Crowe, commedia romantica ambientata a Seattle durante il periodo d’oro del grunge.
Paradossalmente, “Ten” è uno degli album di cui il gruppo si dice meno soddisfatto: la produzione di Rick Parashar conferisce, in effetti, a ogni traccia un suono perfetto e brillante, che in un certo senso non rispecchia l’essenzialità violenta che la band dimostra di possedere in versione live.
Jeff Ament parlò di “uso smodato dell’eco”, di una “patina metal” appiccicata a ogni brano, e più volte sia lui che Vedder espressero il desiderio di voler rimixare, in un futuro, l’intero album (e in effetti, nel doppio best of del gruppo, tutti i brani presi da “Ten” sono rimixati dal loro produttore di fiducia, Brendan O’Brien).
Dichiarazioni della band a parte, sarebbe impossibile immaginare “Ten” in modo diverso. A suo modo è un album unico nella discografia dei Pearl Jam. Nessun loro lavoro futuro suonerà così “commerciale” e allo stesso tempo così sentito e maestoso (anche se “Vitalogy” ci andrà vicino).
“Ten” è uno degli album più amati e importanti dell’intera scena grunge, e ha aperto le porte del circuito mainstream a decine di altri gruppi.
I Pearl Jam, al contrario di tanti loro colleghi, sono ancora in circolazione, e con spirito cavalleresco degno d’altri tempi, continuano a raccontare (un po’ come Bruce Springsteen) le loro storie di comuni tragedie americane, forse senza l’urgenza degli esordi, ma sempre con invidiabile passione.
di Alex Poltronieri