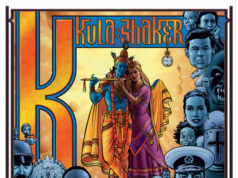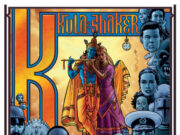Bob Marley & The Wailers
“Exodus”, 1977 (Island Records)
Reggae
di Giuliano Delli Paoli
Il destino corre lungo una scia di fuoco che anima un commando pronto a irrompere al numero 56 di Hope Road, Kingston. È il 3 dicembre del 1976. Un branco di Ali Ağca bussa invano alla porta del papa giamaicano. Pochi istanti e divampa il demone del caos. I proiettili per fortuna si riveleranno miracolosamente fetecchie per Bob Marley, sua moglie Rita, Don Taylor e Louis Griffiths. Il Dio del reggae è salvo. Mostra i fori e suona allo Smile Jamaica appena due giorni dopo aver visto la morte in faccia. Perché le divinità autentiche non appartengono all’assenza. Poi però sparisce. Giustamente, direbbero i sani di mente. Destinazione Island Studios, Londra.
Il 1976 è spartiacque. È l’anno in cui l’esodo muta in necessità, salvezza, sorgente. Per Marley è infatti tempo di librarsi altrove. Di bramare il giorno del giudizio. E invocare un nuovo Mosé. “Le persone che cercano di far diventare peggiore questo mondo non si concedono un giorno libero. Come potrei farlo io?”, le sue parole da scolpire nella pietra.
Il testamento definitivo matura nel cuore che ha appena evitato un proiettile. “Exodus” è il disco più importante del 20° secolo per Time Magazine. Un’esagerazione, forse. Certamente tutt’altro che un’eresia, dato che le sue dieci canzoni amplificano il movimento reggae sotto ogni profilo e ne illuminano i giardini grazie a un Bob Marley inedito, in quanto mosso mai come prima di allora dai richiami di una collera da domare e convertire ora e per sempre in gioia, speranza, coraggio, abbraccio, vita. Quest’ultima, ahinoi, annientata cinque anni dopo da un melanoma diagnosticato nel luglio del 1977, ossia a sole otto settimane dalla pubblicazione dell’album che consacrerà Bob, i Wailers e le I Threes all’immortalità.
Mai più nessuna bugia. Il dado è tratto. E il Rubicone varcato grattando come un angelo ferito la Les Paul Special mentre il tempo di Carlton Barrett e il passo di Aston Barrett ne cullano il canto, come dei Michael Collins e Buzz Aldrin strafatti di erba. Durante le sessioni di “Exodus”, Marley ritrova il suo vecchio amico e produttore Lee “Scratch” Perry, e opta per Junior Marvin alla chitarra solista. “Natural Mystic” introduce gli umori afflitti che inseguono una vendetta da consumare a braccia aperte. “So Much Things To Say” è al contrario predica e allegria.
“Non sono venuto per combattere carne e sangue. Ma la malvagità spirituale”. “Guiltiness” apre invece alla politica sociale del Bob visionario. Il flusso orchestrato dai suoi sodali inscena un dondolio epico, memorabile. Trombe, cori, pelli e corde anestetizzano ogni malessere. È il preludio alla seconda ondata mistica. Alla psichedelia pagana di “Heathen”. L’ipnosi spunta così a sorpresa. Come d’altronde la fuga: Jah è finalmente tra noi e ci invita ancora una volta all’esodo. Le speranze rastafariane di “Exodus” guardano all’isola che c’è. È il brano che anticipa per certi versi i Talking Heads in modalità Parigi-Dakar di “Crosseyed And Painless”. Il safari inscenato da Marley è però, manco a dirlo, biblico, e muove a processione.
Ciò che rende “Exodus” “inarrivabile”, quantomeno distaccato dai dischi di Marley che lo precedono, è l’ira ben riposta mista a un’illuminata bramosia. È come se a Londra il musicista e cantore avesse trovato una pace assaporata ma mai gustata del tutto. Altrimenti non si spiegherebbe il classico dei classici. Il poster appeso al muro di svariate generazioni. “Jamming” è amore (e musica) universale. Il sacrificio vivente, per dirla con Bob stesso, che non va sprecato. Che tutti dovrebbero suonare e cantare tenendosi per mano. Senza più recinti. Diretti come apostoli verso il monte Sion.
Dicevamo di epica e religione. “Exodus” espone però anche il lato più “umano” di Bob Marley. La sua nemesi meno “spiritualizzata” appare in “Waiting In Vain”. Bob è sorprendentemente “guascone”, attendista, donnaiolo. Ansima e osanna a briglie sciolte Cindy Breakspeare, Miss Mondo 1976 e madre di Damian Marley. Il suo cuore pulsa in una ballata un po’ nenia reggae e un po’ libidine da gettare ai quattro venti, attraverso un assolo dolcissimo e in salsetta blues a un quarto dal solco.
Immaginiamo poi di riunificare le religioni del mondo e concentrale in un unico messaggio. Ebbene, cosa canteremmo in coro? “Three Little Birds”. Ovverosia i tre porcellini (tra)vestiti da uccellini che beccheggiano felici e mai più pavidi alle porte di un paradiso terrestre con capitale Kingston. Non c’è paranoia che tenga: “‘Cause every little thing is gonna be alright!”. È l’ennesimo instant-classic di un album che espone una versione più compatta di Bob Marley e della sua ciurma anche sul piano meramente produttivo. Il sound è corposo e tutto vibra con l’anima interrotta del cantautore giamaicano in gita forzata a Londra, che sul finale decide bene di rispolverare “One Love”, pubblicata nel 1965 dai Wailers nel loro primo album, “The Wailing Wailers”, e contenente alcune strofe di “People Get Ready”, stampata lo stesso anno dagli Impressions di Curtis Mayfield. Stavolta le I Threes sono figlie di Maria ai Caraibi. E intonano un coretto che ha acceso ovunque un numero pressoché incalcolabile di falò.
“Exodus” si rivelerà un notevole successo di pubblico, raggiungendo il numero 8 della classifica britannica (dove rimarrà in top 40 per 42 settimane) e il numero 20 della classifica di Billboard negli Stati Uniti. La Island capitalizzerà quindi al massimo il richiamo globale del disco, facendo uscire come singoli ben sette brani. A “Exodus” seguiranno l’onestissimo “Kaya”, registrato quasi in contemporanea, che regalerà qualche altra hit indimenticabile come “Is This Love?”. E soprattutto altre due piccole grandi perle, non solo del reggae ma della musica tutta, ossia “Survival” e in particolare “Uprising”. Entrambe dilateranno le dieci parabole di “Exodus”, dando vita a una sorta di doppio vangelo del messia Bob, che nonostante l’implacabile malattia continuerà a regalare linfa all’universo mondo, così come a prendere a cuore, alla sua inconfondibile maniera, le inenarrabili sofferenze di paesi come il dimenticato Zimbabwe e ovviamente della sua Giamaica, ritrovata pochi mesi dopo l’esodo. Ci sarebbe pure una “Africa Unite”, il cui testo ci dice più o meno tutto ancora oggi.
Insomma, per abbracciarci un’ultima volta, e al di là delle ovvie differenze: Bob Marley sta alla musica popolare come Thomas Sankara sta alla politica. Ed “Exodus” resterà fino alla notte dei tempi il suo proclama più vivido. L’apologia totalizzante di uno stile unico.